Plusvalenze: perché la Juve è stata punita e il Napoli non lo sarà mai
Perché le plusvalenze della Juve sono state punite e quelle del Napoli e delle altre squadre di serie A non sono state sanzionate? Vi spieghiamo i motivi.

Si parla tanto di plusvalenze, spesso demonizzandole. Ma se i comportamenti della società di calcio sono improntati al rispetto delle regole che governano questo ricavo tipico, caratteristico, cruciale per la sopravvivenza di una azienda calcio, allora “plusvalenza non è una parolaccia”. Ma cosa sono le plusvalenze e le minusvalenze (il loro contrario)? Semplificando, si tratta di ricavi o costi derivanti dalla compravendita dei calciatori il cui valore è espresso in bilancio sotto la voce «diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori», ovvero, per dirla in modo semplice, i cosiddetti cartellini.
Utilizziamo l’esempio di Higuaín, il cui cartellino fu acquistato dal Napoli per circa 40 milioni di euro (37 + 3 di bonus) e fu accompagnato da un contratto di quattro stagioni.
Se il calciatore è utile alla società che l’ha acquistato per quattro stagioni, il costo del suo contratto, come corretta correlazione, deve essere suddiviso uniformemente nei conti economici relativi a ognuna delle stagioni; imputare l’intero costo (elemento negativo) nel primo anno, infatti, striderebbe con la correlazione all’utilità (elemento positivo) pluriennale del cartellino.
Tale processo, definito di ammortamento, consente pertanto di distribuire il costo complessivo del cartellino correlandolo all’arco temporale lungo il quale esso fornirà la propria utilità. L’ammortamento non è altro, quindi, che un costo che esprime “il consumo” delle prestazioni di un calciatore in un determinato anno.
Parallelamente, e senza addentrarci in eccessivi tecnicismi, supponiamo che il valore del cartellino diminuisca, intuitivamente, di un 25% al termine di ogni stagione, visto che la sua utilità si ridurrà progressivamente man mano che si avvicineranno la scadenza del contratto e il momento in cui la società perderà i propri diritti allo sfruttamento, economico e sportivo, del calciatore.
Di conseguenza, alla fine della prima stagione il valore residuo del cartellino di Higuaín in bilancio (Net Book Value) sarebbe stato di 30 milioni, al termine della seconda stagione di 20 milioni e così via. Proprio tale valore residuo rappresenta il termine di confronto con il prezzo di cessione al fine di determinare l’entità della plusvalenza o della minusvalenza.
Se dunque al termine della terza stagione il Napoli ha ceduto il calciatore per 90 milioni e il suo valore residuo era di 10 milioni (i 40 milioni iniziali rettificati dagli ammortamenti di 10 milioni l’anno per tre anni), la società ha realizzato una plusvalenza di 80 milio ni (!) e non di 50 (pur avendo ceduto per 90 milioni un cartellino pagato, originariamente, 40).
La plusvalenza non è, quindi, l’ammontare di denaro incassato (il prezzo di vendita) e neppure la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita: E’ la differenza (positiva) tra il prezzo di vendita e il valore del calciatore iscritto in bilancio al momento della vendita.
Secondo lo stesso esempio, la società avrebbe subito una minusvalenza se avesse ceduto il giocatore a un prezzo inferiore ai 10 milioni di euro.
Ma allora perché quando si parla di plusvalenza, si pensa ad una diavoleria?
Perché con le plusvalenze spesso si coprono le perdite di gestione e si gonfiano anche i costi nei bilanci attraverso l’incremento del valore dei calciatori con le cosiddette “plusvalenze a specchio”.
Lungi da me il solo pensiero di addentrarmi in ragionamenti legali (lasciamoli ai giuristi), mi posso però permettere di fornire il mio contributo dal punto di vista tecnico contabile.
Facciamo un esempio pratico. La società del Borgorosso Football Club acquista le prestazioni (il cartellino) del calciatore Guardavaccaro per tre anni a un prezzo di 30 milioni di euro (mentre il suo reale valore di mercato è di 10 milioni) e utilizza un metodo di ammortamento che prevede una ripartizione del “consumo” del calciatore non proporzionale, ma a quote decrescenti. Ciò significa che il Borgorosso Football Club presume di consumare (utilizzare) Guardavaccaro non per 10 milioni di euro all’anno ma, ad esempio, per 20 milioni il primo anno e poi per 5 milioni per ciascuno dei successivi due anni rimanenti. Al termine del primo anno, per il Borgorosso Football Club il valore di bilancio di Guardavaccaro, quindi, è di 10 milioni. Se il Borgorosso Football Club vende Guardavaccaro all’Atletico Manontroppo per 40 milioni di euro ha realizzato una plusvalenza di 30 milioni di euro! Ovviamente i due club sono conniventi e l’Atletico Manontroppo, per sistemare il suo bilancio, fa la stessa identica cosa con il suo calciatore Mezzapippa.
Alla fine, entrambi i club avranno coperto perdite di bilancio con le plusvalenze fittizie di due manovali del pallone senza alcun movimento di denaro.
Il problema, però, non è l’assenza di movimentazione di danaro perché, in linea di principio si tratta di operazioni legali.
Il problema non risiede neppure nel valore eventualmente gonfiato dei calciatori perché i valori sono grandezze stimate sulla base di una analisi soggettiva che risulta difficile confutare (fino a quando non saranno trovate soluzioni legislative adeguate) e di cui abbiamo già parlato su questo giornale quando abbiamo esaminato la differenza tra prezzo e valore.
E allora perché le plusvalenze della Juve sono state punite e quelle del Napoli e delle altre squadre di serie A non sono state sanzionate?
Perché la Juventus, essendo quotata in Borsa (come la Lazio), nella redazione del bilancio deve obbligatoriamente seguire i principi contabili internazionali IAS/IFRS che stabiliscono che gli scambi non debbano essere considerati due operazioni indipendenti (un acquisto e una contestuale cessione) ma debbano essere trattati come permute, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (i contratti, invece, le trattano come due operazioni indipendenti).
E le permute, sempre in base ai principi IAS/IFRS, richiedono l’applicazione di regole contabili differenti che, in alcuni casi (per la Juventus 10 casi su 15), portano a NON poter iscrivere la plusvalenza.
E la Juventus, nei propri bilanci, laddove avrebbe dovuto illustrare i criteri di valutazione, non ha mai affermato, non ritenendo quegli scambi operazioni qualificabili come permute, di applicare la relativa disciplina contabile.
Le società di calcio non quotate (come il Napoli), invece, redigono il bilancio non in base ai principi internazionali IAS/IFRS ma secondo la disciplina del codice civile così come interpretata dai principi contabili nazionali emanati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) dove gli scambi di giocatori possono essere qualificati come permute.
Questa confusione è stata parzialmente sanata solo nel 2023 quando l’UEFA, nelle nuove norme previste per il Fair Play Finanziario, ha modificato, senza alcun effetto retroattivo, la disciplina contabile degli scambi.
 Chi č Milton Pereyra, talento argentino del Napoli: le caratteristiche
Chi č Milton Pereyra, talento argentino del Napoli: le caratteristiche Chi č Alisson Santos, la nuova ala funzionale del Napoli: caratteristiche e skills
Chi č Alisson Santos, la nuova ala funzionale del Napoli: caratteristiche e skills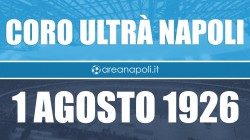 "1 agosto 1926", coro e testo. Auguri Napoli, sono 99
"1 agosto 1926", coro e testo. Auguri Napoli, sono 99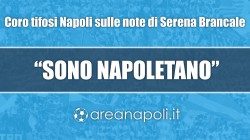 "Sono napoletano", coro e testo
"Sono napoletano", coro e testo Guarda tutti i video pubblicati su AreaNapoli.it
Guarda tutti i video pubblicati su AreaNapoli.it Inter Inter | 55 |
 Milan Milan | 50 |
 Napoli Napoli | 46 |
 Juventus Juventus | 45 |
 Roma Roma | 43 |
 Como Como | 41 |
 Atalanta Atalanta | 36 |
 Lazio Lazio | 32 |
 Udinese Udinese | 32 |
 Bologna Bologna | 30 |
 Sassuolo Sassuolo | 29 |
 Cagliari Cagliari | 28 |
 Torino Torino | 26 |
 Genoa Genoa | 23 |
 Cremonese Cremonese | 23 |
 Parma Parma | 23 |
 Lecce Lecce | 18 |
 Fiorentina Fiorentina | 17 |
 Pisa Pisa | 14 |
 Verona Verona | 14 |



















